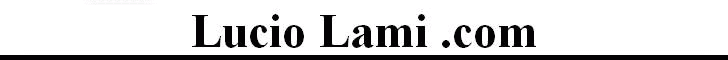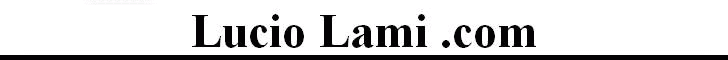» I libri »
Il Re di maggio «
Il Re di maggio
Umberto II: dai fasti del «Principe bello»
ai tormentati anni dell'esilio
(Di seguito si propongono la prefazione e il
primo capitolo)
Prefazione
 Nell'autunno
del 1979 chiesi all'amico Falcone Lucifero, che ricopriva la carica
di ministro della Real Casa, se gli sarebbe stato possibile fissarmi
una serie di incontri con re Umberto, in esilio a Cascais. Volevo
intervistarlo e avere la sua opinione sull'interpretazione storica
che si andava radicando a proposito della caduta della monarchia
sabauda. Pensavo che a più di trent'anni dagli eventi egli
potesse dire qualcosa di meno ufficiale di quanto, molto cautamente,
aveva detto fino a quel momento in altre interviste, compresa quella
rilasciata, proprio in quel periodo, alla televisione italiana.
Nell'autunno
del 1979 chiesi all'amico Falcone Lucifero, che ricopriva la carica
di ministro della Real Casa, se gli sarebbe stato possibile fissarmi
una serie di incontri con re Umberto, in esilio a Cascais. Volevo
intervistarlo e avere la sua opinione sull'interpretazione storica
che si andava radicando a proposito della caduta della monarchia
sabauda. Pensavo che a più di trent'anni dagli eventi egli
potesse dire qualcosa di meno ufficiale di quanto, molto cautamente,
aveva detto fino a quel momento in altre interviste, compresa quella
rilasciata, proprio in quel periodo, alla televisione italiana.
L'appuntamento per l'inizio degli incontri mi fu
fissato per il 23 ottobre, alle 17,30. Partii qualche giorno prima
perché volevo rivedere Lisbona, visitando i luoghi e gli
ambienti frequentati da Umberto, specie nei primi anni d'esilio:
il Barrio Alto, la Rua das Taipas, il locale «La Viela»,
dove l'ex sovrano si era recato a lungo e frequentemente per ascoltare
Amalia e Celeste Rodriguez, le regine del fado.
Nei dintorni di Lisbona interrogai anche molta gente
della strada per farmi un 'idea di che cosa pensassero i portoghesi
dell'ex re d'ltalia, e scoprii che i giudizi erano diversi a seconda
dell'età degli interrogati: i vecchi avevano una simpatia
spiccata per lui e ricordavano quasi con affetto che gli era toccata
la stessa sorte di Carlo Alberto, di finire cioè a macerarsi
nei ricordi davanti all'Oceano. Lo consideravano un po' portoghese,
quasi uno di famiglia.
I giovani, invece, spesso neppure sapevano chi era,
o se lo sapevano erano del tutto indifferenti alla sua vicenda.
Dopo la rivoluzione dei garofani, sembravano aver archiviato la
storia del tempo dei regni e delle dittature. Tra di loro, alcuni,
più rispettosi, lo consideravano un padre sfortunato con
i figli sempre nei guai, altri, i più malevoli, dicevano
di averlo intravvisto a La Boca, in spiaggia, «a guardare
i marinai, più che il mare».
Mi parve che l'esilio avesse, tra i tanti inconvenienti,
quello di lasciare Umberto disarmato di fronte ai pettegolezzi e
agli assalti della stampa che si andava occupando dei reali sempre
meno in chiave storica e sempre più in versione scandalistica:
dalla memorialistica degli anni Cinquanta e Sessanta si stava passando,
soprattutto in Italia, allo «scoopismo» dei fogli popolari,
visto che le disavventure della famiglia reale erano diventate uno
dei propellenti preferiti per tonificare le vendite, soprattutto
dei periodici.
Il re mi ricevette la prima volta, di pomeriggio,
a Villa Italia, nel salotto del pianoterra dov'era solito incontrare
i visitatori. Vestiva di grigio, era moderatamente abbronzato, molto
affabile. Mi fece accomodare su un divanetto sopra il quale era
appeso, incorniciato nel vetro, uno stendardo tricolore. Mi disse
di aver letto il mio libro sul «Savoia Cavalleria» in
Russia e, indicandomi il quadro, aggiunse: «Quello, come vede,
è lo stendardo del suo reggimento».
«Non può essere», risposi, interrompendolo
istintivamente e violando subito l'etichetta, «quello di Savoia
era bruciacchiato, fatto a pezzi e ricomposto, quando il colonnello
Bettoni, nel dopoguerra, venne a riconsegnarglielo».
Sorrise compiaciuto. «È vero», disse. «È
una copia. L'originale lo tengo nella mia camera da letto».
Ebbi subito l'impressione che non sarebbe stato facile
intrattenerlo su temi scabrosi. Aveva l'atteggiamento di chi ha
già scritto la sua storia e non intende apporvi modifiche.
Mi trattenni per una settimana. Di giorno in giorno fissavamo l'incontro
per l'indomani. Dopo le prime due interviste, mi invitò a
proseguire i lavori nel suo studio, al piano di sopra. Con grande
tatto, non si sedette alla scrivania, ma accanto a essa, facendomi
accomodare di fronte a lui.
A mano a mano che le conversazioni procedevano, il
suo eloquio si faceva più discorsivo, quasi avesse superato
il suo riserbo e la naturale timidezza. A volte, su temi che non
gradiva, dava risposte brevi, ora evasive ora lapidarie. Altre volte,
su argomenti che lo interessavano, faceva lunghe digressioni, pregandomi
poi di considerarle «off the records».
Un giorno dovette lasciarmi solo, per pochi minuti, e rientrando
mi trovò intento a leggere i dorsi dei libri della sua biblioteca.
«Quelli, mi disse, sono tutti volumi di storia scritti nell'immediato
dopoguerra che mio padre si fece mandare in Egitto e che postillò
a matita. Se lei volesse, un giorno, potrebbe venire a fare una
vacanza da queste parti e io potrei farglieli consultare: sono certo
che ne uscirebbe un libro molto diverso da quelli che si scrivono
oggi».
Mi mancò sempre il tempo di onorare quell'invito
e ancor oggi me ne rammarico. Mi chiedo anche se parte di quei libri
non siano finiti, come altri, sulle bancarelle.
Parlando del periodo della reggenza, dissi al re
che le documentazioni sui suoi spostamenti erano molto povere. Rimase
sorpreso. L'indomani mi fece trovare quattro grossi faldoni pieni
di fogli accuratamente datati: erano i diari quotidiani tenuti dalle
sue ordinanze nei quali era registrato, ora per ora, tutto ciò
che Umberto aveva fatto dal 1943 al 1945.
Fu, quello, un dono prezioso del quale mi sono ampiamente servito
nella stesura di questo libro.
Mi disse anche che stava lavorando sulle carte d'archivio
di Casa Savoia. Sapevo dell'esistenza di quei documenti, murati
a Roma durante l'occupazione tedesca, spediti in Egitto per volere
di Vittorio Emanuele III ed evidentemente arrivati a Cascais. Mi
dicono che ora sarebbero secretati per cinquant'anni, sigillati
in custodie cilindriche e affidati a fedelissimi, in luoghi sicuri.
A più riprese portai il discorso sull'Italia
dei nostri giorni, ma ebbi sempre risposte cautissime, da un uomo
che continuava a considerarsi re di tutti gli italiani. Soltanto
una volta, mentre scendevamo in giardino, alla mia domanda se ci
fossero dei politici italiani che tenevano contatti con lui, mi
rispose che, nella maggior parte, lo evitavano. Mi raccontò
anche, con un pizzico di ironia, che non molto tempo prima Andreotti,
di passaggio a Lisbona, «non si era fatto vivo», pur
essendo uno dei commendatori della Corona.
Rientrato a Milano, citai quell'episodio in un mio
articolo, e prontamente il re mi mandò a dire, tramite Falcone
Lucifero, che quel commento non era stato fatto durante l'intervista,
ma in privato, e che non avrebbe dovuto essere pubblicato. Mi scusai.
Dopodiché mi arrivò da Cascais una foto di Umberto
con dedica.
Il re morì senza ottenere di poter rientrare
in Italia. Molti sostengono che soffrisse, tormentato dalla nostalgia.
Parlandone con lui, ebbi l'impressione che non fosse la nostalgia
ad angustiarlo, ma il senso della giustizia violata e della storia
manomessa: un sentimento del quale i suoi detrattori erano fortemente
carenti.
La sua casa non aveva nulla di regale: era una specie
di museo che egli si era pazientemente costruito attorno per attendere
la morte in sintonia con la millenaria storia della sua famiglia.
Mi diede l'impressione che fosse perfettamente consapevole di avere
avuto dal destino («la Provvidenza», diceva lui) l'amaro
compito di chiudere un'epoca così lunga, il cui valore storico
non era bastato a controbilanciare gli errori di suo padre e degli
italiani, a meno di cent'anni dall'unità d'Italia.
Per un giudizio definitivo su Umberto II bisognerà
attendere ancora per anni: molti documenti sono ancora irreperibili,
secretati, nascosti. Ma molti passi avanti sono stati possibili:
le carte riservate del Dipartimento di Stato americano, che qui
riporto, già consentono un notevole cambiamento di giudizio
sui rapporti tra il governo Usa e la monarchia italiana. Gli studi
di Malnati sul referendum rendono l'affaire dei brogli molto più
che un sospetto.
La conclusione che già si può trarre
è che Umberto si comportò nei riguardi del fascismo
come il novanta per cento degli italiani, pur essendo intimamente
convinto che il regime era per molti versi inaccettabile. La singolarità
della sua vicenda sta proprio in questo, nel non aver potuto usufruire,
come la maggior parte dei suoi connazionali, della grande rimozione
storica di quel periodo, e nell'aver pagato in solitudine un prezzo
sproporzionato anche per molte colpe che non erano sue.
1. Un giorno, una vita
La mattina del 9 settembre 1943 un sole tiepido nel
cielo terso illuminava gli spalti dell'antico castello di Crecchio,
vicino a Chieti, appartenente ai duchi di Bovino. Il duca Giovanni
de Riseis, senatore del Regno, e sua moglie, la duchessa Antonia
Gaetani dell'Aquila d'Aragona, dama di compagnia della regina, vi
trascorrevano in quei giorni una vacanza di guerra, da sfollati
in casa, in compagnia della figlia Teresa e dei nipoti.
In quelle ore, la conversazione tra i padroni di casa riguardava
ossessivamente un solo tema: che cosa sarebbe accaduto all'Italia
dopo la proclamazione dell'armistizio che Badoglio aveva improvvisamente
annunciato alla radio, in termini piuttosto ambigui, il giorno prima?
C'era l'armistizio con gli anglo-americani, ma come avrebbero reagito
i tedeschi, alleati abbandonati dall'Italia?
I commenti vennero interrotti bruscamente verso le
dieci, quando Bice, una delle nipoti, che se ne stava nel parco
studiando tedesco con fräulein Buckberger, vide arrivare a
piedi, dalla lontana entrata del parco il principe ereditario, Umberto,
che le disse di avvertire la nonna perché davanti al cancello,
chiuso, erano ferme molte automobili con a bordo il re, la regina
e numerosi ufficiali.
Bice si precipitò a dare l'allarme. Il giardiniere,
noto in casa per essere dichiaratamente comunista, fu spedito ad
aprire, ma non si sa se per aver sbagliato le chiavi o perché
volesse prendersi qualche soddisfazione, impiegò un tempo
interminabile prima di far entrare il corteo (1).
Tra lo stupore dei padroni di casa, dalle macchine
scesero effettivamente re Vittorio Emanuele III, la regina Elena,
il generale Puntoni, aiutante di campo del re, il generale Badoglio,
capo del governo, il generale Gamerra, aiutante di Umberto, gli
ufficiali d'ordinanza Di Campello e Litta, il colonnello Buzzaccarini
e altri personaggi che si aggiungevano man mano, oltre agli autisti
e ai domestici della regina.
Il principe Umberto, che aveva preceduto tutti risalendo
il parco a piedi, aveva dato una prima spiegazione alla strana visita:
la famiglia reale e il governo, per sottrarsi alle ire dei tedeschi,
stavano per trasferirsi in una località non occupata dagli
ex alleati e neppure dagli anglo-americani, ed erano diretti a Pescara.
Costretti a fermarsi per un contrattempo, su suggerimento dello
stesso Umberto avevano deciso di far tappa al castello di Crecchio,
dove il principe aveva trascorso con la moglie, anni prima, un piacevole
soggiorno ospite dei Bovino.
La duchessa, dopo il saluto concitato agli ospiti
inattesi, si dedicò alla loro sistemazione: fece accomodare
i reali e i generali, dirottò gli ufficiali più giovani
nei salotti al piano terra, fece preparare la sua camera da letto
per il re e per la regina che dovevano rinfrescarsi, sloggiò
la nipote Bice dalla sua camera per metterla a disposizione del
principe, mobilitò il personale, diede ordine al cuoco napoletano,
don Alfonso, di procurarsi presso i contadini dei polli e di preparare
un pasto caldo per una quarantina di persone.
Il duca di Bovino intratteneva intanto Badoglio,
il quale si affrettò a spiegargli un po' confusamente che
«stava portando la famiglia reale in un lembo di terra libero,
per evitarne la cattura da parte dei tedeschi e per organizzare
un nuovo esercito in modo che gli inglesi potessero credere alle
intenzioni italiane di voler lottare alla formazione di un nuovo
mondo libero». Disse anche che «quell'operazione doveva
mostrare agli italiani quale fosse per il bene comune la via da
seguire, in modo che tutti comprendessero che si stava giocando
il tutto per tutto e che quindi tutti avrebbero dovuto seguire l'esempio
dei governanti» (2).
Dopo che gli ospiti si furono rinfrescati, vennero
poste delle sedie nel cortile perché si potesse attendere
con calma l'ora del pranzo.
Pochi, tra i sopraggiunti, sembravano rendersi conto
di come quel loro viaggio affannoso apparisse a qualsiasi osservatore
come una tragica fuga e anche come l'ultima avventura della monarchia
sabauda. Il re sembrava tranquillo. Badoglio, dopo aver manifestato
i rischi corsi viaggiando in una zona infestata dai tedeschi, sosteneva
con calore che entro quindici giorni tutti i presenti sarebbero
stati di nuovo a Roma. A chi gli chiedeva in quali mani fosse stata
affidata la difesa della capitale e in quali le redini delle Forze
armate, il maresciallo rispondeva infastidito di aver dato personalmente
gli ordini del caso.
Mentre la regina era andata a distendersi su un letto,
gli ufficiali del seguito affollavano i salotti scambiandosi allarmate
e contrastanti opinioni. La duchessa di Bovino, dopo aver consolato
la regina (che, in lacrime, le aveva parlato di sua figlia Giovanna,
vedova, di Mafalda partita per la Bulgaria e della quale non sapeva
più nulla, di Umberto), si aggirava da un locale all'altro
impartendo ordini, ma trovò il tempo di ascoltare molti scampoli
di conversazione e di allarmarsi sempre più per le cose che
veniva a sapere. Lo stesso principe Umberto l'aveva impressionata
commentando tristemente la situazione e manifestando la sua contrarietà
(3).
Tra la duchessa e il principe, dopo i convenevoli
iniziali, la conversazione aveva assunto toni gravi e preoccupati.
«Sul volto di donna Antonia aumentava un'espressione di sbalordimento
e quasi di costernazione. A un certo punto, guardando il principe
negli occhi e tenendo le mani giunte aveva sussurrato: "Conosce
i miei sentimenti per la Casa, quindi la scongiuro, torni a Roma!".
E col passare delle ore espresse a più riprese lo stesso
voto» (4).
Umberto, che era tormentato da quell'idea già
dalla sera prima, da quando cioè Badoglio gli aveva ordinato,
come superiore in grado, di partire con i genitori, raggiunse in
cortile i generali Gamerra e Puntoni che stavano discutendo proprio
del suo problema. Il principe, appoggiato a una colonna dell'arcata,
attese che anche il re e Badoglio si avvicinassero, per esporre
ancor una volta il suo desiderio di tornare indietro. Ma Badoglio,
che si era seduto sul parapetto del pozzo, divenne paonazzo e lo
interruppe subito, dicendo di avergli già impartito un ordine
in proposito. Il principe, pallido, trovò la forza di rispondere:
«Per decisioni come questa, attendo ordini da Sua Maestà».
Ma anche Sua Maestà non ebbe il tempo di replicare perché
Badoglio, battendo un pugno sul parapetto, ribadì con veemenza:
«Lei porta le stellette. È un soldato e mi deve obbedienza».
Il re rimase in silenzio.
Lo scontro fu interrotto dall'arrivo di Acquarone,
che era stato spedito a Pescara per vedere se tutto era tranquillo.
Il ministro della Real Casa riferì che i tedeschi sfilavano
sulla Tiburtina, ritirandosi senza sparare e ignorando i duemila
avieri e ufficiali del vicino campo d'aviazione. Stranamente, la
notizia non stupì nessuno: né Badoglio, che durante
il trasferimento da Roma a Crecchio si era fatto prestare il cappotto
del principe, ma, timoroso di incontrare i tedeschi, aveva risvoltato
poco onorevolmente le maniche per nascondere i gradi; né
il re, che sembrava convinto che gli ex alleati fossero in fuga
verso il nord; né i generali, alcuni dei quali pensavano
in cuor loro, come scrissero poi, che tra il vertice militare italiano
e quello tedesco fosse stato raggiunto un accordo segreto che prevedeva
l'abbandono di Roma da parte del primo, in cambio dell'incolumità
dei sovrani e del governo.
Umberto restava angustiato. «A tenermi tanto
agitato erano le conseguenze politiche di un avvenimento che si
stava svolgendo in modo ben diverso da come era stato ipotizzato
e progettato. A me, giunto a Roma da poche ore, era stato detto
che il re aveva accettato il piano di trasferire la famiglia reale
e il governo in altro luogo del territorio italiano che non fosse
occupato dai tedeschi o dagli americani. Questo per garantire la
continuità del governo e una politica che era favorevolmente
iniziata il 25 luglio. Si dice che durante il viaggio io dissentivo.
È vero, ma non dalla decisione di mio padre, che mi è
sempre parsa meditata, ma da come i fatti si andavano evolvendo.
Era evidente in quelle ore che, nonostante le assicurazioni che
Badoglio continuava a dare al re, preoccupatissimo, buona parte
dei ministri non si erano presentati all'appuntamento, evidentemente
perché non informati. Io mi dicevo, in quella notte drammatica:
che cosa accadrà domani quando questi ministri si alzeranno
dal letto e scopriranno che noi non ci siamo più? Diranno:
"Ecco, loro se ne sono andati e hanno lasciato noi nelle peste".
Con quale animo ci saremmo ripresentati a Roma, di lì a pochi
giorni, come si pensava allora, e avremmo incontrato questi membri
del governo? O peggio, se fossero stati arrestati, deportati, uccisi
dai tedeschi, quali giustificazioni avremmo dato?» (5).
Verso le tredici, la padrona di casa annunciò
che il pranzo era pronto «per il primo turno». La regina
aveva chiesto di rifocillarsi lontana da occhi indiscreti, così
mentre gran parte dei militari attendeva il secondo turno, per il
quale si allestivano tavoli in altri locali, nel salone principale
entrarono i sovrani, i duchi di Bovino, la loro figlia Teresa, Badoglio,
il principe e il suo aiutante di Campello, mentre il servizio in
tavola veniva affidato non ai camerieri ma ai due giovani nipoti
del duca, Giovanni e Luigi Cafiero. Quest'ultimo, emozionato, finì
per rovesciare un grande vassoio di frutta per tutta la stanza,
ma nessuno ci fece caso perché anche a tavola la conversazione
continuava a essere un po' nevrotica e surreale. Solo Umberto ora
taceva (6).
Vittorio Emanuele ironizzò sulla sua sorte,
dicendo: «Tutto questo ci succede per una manovra elettorale»;
e spiegò ai presenti, attoniti, che Roosevelt aveva voluto
a tutti i costi annunciare la resa dell'Italia il giorno prima perché
proprio in quelle ore aveva un'importante riunione elettorale. «Ma
torneremo a Roma prestissimo», disse a un certo punto, e rivelando
che il suo portafogli conteneva solo mille e duecento lire, spiegò
che aveva portato denari solo per un viaggio breve.
Badoglio, che cercava di tenere il bandolo della conversazione,
lasciava intendere di aver tutto pianificato: «Mi sun testòn
piemonteis», disse in dialetto, «e se dico una cosa
è perché ne sono sicuro: tra quindici giorni, al più
tardi, saremo di ritorno».
Acquarone sosteneva di prevedere il rientro dopo solo tre giorni
di assenza e di non avere, per questo, portato con sé che
il vestito che indossava.
Indifferenti al mutismo di Umberto, i commensali
tentavano di celiare. Qualcuno disse, rivolto al maresciallo Badoglio:
«Chissà dove sarà a quest'ora Mussolini, prigioniero
al Gran Sasso... ». E lui prontamente: «A quest'ora
l'avranno già liberato». Quasi intuendo quella realtà
ancora ignota ai fuggiaschi, il re chiosò, per stuzzicare
il maresciallo: «Almeno lui mi è rimasto fedele per
vent'anni».
La regina non gradiva questi commenti disinvolti.
A un tratto, con aria triste, disse che l'esperienza le aveva insegnato
che le rivoluzioni si sa dove cominciano e non dove finiscono, e
ricordò la fine dei Romanov, in Russia (7).
Il pranzo fu rapido: brodo ristretto, pollo lesso,
insalata e frutta. E fu più o meno uguale anche per gli ospiti
del secondo turno, tra i quali le discussioni non ebbero sosta.
Verso le quindici il gruppo si accomiatò e
il corteo di una quindicina di automobili prese la strada verso
il mare. Ma all'imbocco con la Tiburtina incappò in una colonna
motocorazzata tedesca che marciava verso Pescara e dovette lasciarla
passare. Molto singolarmente, i tedeschi ignorarono quel corteo
di vetture ufficiali e militari ferme sul ciglio che, alla fine,
si accodarono alla colonna. Ormai era evidente che qualcuno, all'insaputa
dei più, a cominciare da Umberto, aveva trattato nelle ultime
ore l'immunità dei fuggiaschi. Ma chi? (8).
Mentre la colonna reale si avviava verso Pescara,
le varie strade che andavano in direzione della costa si intasavano
di veicoli civili e militari italiani. Ufficiali di ogni arma e
grado, rimasti senza ordini, o ignorandoli, avevano abbandonato
Roma e affluivano nella zona dove era prevista la presenza del governo.
Il generale Ambrosio, capo di Stato maggiore generale, arrivò
a Chieti e si installò in albergo, mentre centinaia di ufficiali
si riversavano nella cittadina, convinti che quella sarebbe stata
la sede del comando, in attesa del rientro a Roma. A detta di molti,
Ambrosio, che pure era al corrente della destinazione finale dei
fuggiaschi, non smentì questa convinzione, più che
plausibile per tutti, visto che Roatta, capo di Stato maggiore dell'esercito,
si agitava per impiantare presso il comando di Divisione di Chieti
gli uffici destinati a riprendere contatti con tutto l'esercito.
E fu a Chieti che anche gli ultimi dubbi sulle effettive intenzioni
dei tedeschi nei confronti dei «traditori italiani»
furono dipanati, quando le notizie captate dai centri di ascolto
militare rivelarono che Genova, La Spezia, Trieste e altre città
erano già state occupate dagli ex alleati nel volgere di
poche ore.
Quando la comitiva del re giunse a Pescara erano
all'incirca le sedici. All'aeroporto nessuno sapeva nulla di quell'arrivo,
tanto che non fu schierata la guardia. In compenso la calma era
assoluta. Il re, infreddolito e affaticato, convocò nella
palazzina del comando una specie di consiglio della corona, presenti
il generale Ambrosio, il generale Puntoni, l'ammiraglio De Courten
(marina) e il generale Sandalli (aviazione), facenti parte del governo,
ai quali si aggiunsero poi Badoglio, Acquarone, Gamerra e altri.
Umberto fu lasciato con la madre.
Si trattava di decidere dove il governo dovesse rifugiarsi.
Non a Pescara o nei dintorni, come credevano molti, visto che forti
malumori serpeggiavano sia tra i militari che tra i civili per quella
fuga e che pochi ormai credevano nella ritirata indolore dei tedeschi.
Non in Sicilia o in Tunisia, presso gli anglo-americani, come voleva
Badoglio, avendo contro il re e gli altri generali. Il sud d'Italia
poteva essere la soluzione, visto che città come Brindisi
erano sgombre sia dalle truppe di invasione che dai germanici, ma
al momento non si avevano notizie della corvetta Baionetta che fin
dall'alba aveva avuto ordine di salpare per Ortona, quando si era
rivelato irrealizzabile il piano, predisposto da giorni, di trasferire
il governo in Sardegna.
Qualcuno proponeva di usare gli aerei, ma il re temette
che la partenza di un numero ridotto di persone trasformasse il
«trasferimento del governo» in fuga. C'era poi, come
disse Badoglio, il problema che la regina non sopportava il volo.
Mentre queste discussioni si protraevano nella palazzina comando,
Umberto, lasciata la madre, cercava di parlare con persone fidate
nel tentativo di capire, una volta per tutte, quel che stava realmente
accadendo.
Fu solo in quei momenti che il principe si rese totalmente
conto che Badoglio aveva mentito e che le Forze armate erano state
abbandonate a loro stesse. Quando, vent' anni dopo, chi scrive pose
a Umberto in esilio la domanda se in quelle ore avesse collegato
l'abbandono dei soldati con un possibile accordo dei vertici italiani
con i tedeschi, si sentì rispondere che l'ipotesi sarebbe
parsa, in quelle ore, possibile ma fantasiosa. Ma il dubbio doveva
aver colpito profondamente anche l'erede al trono nelle tragiche
ore di Pescara.
In quei momenti di sosta, Umberto, infatti, incontrò
un amico, il principe Carlo Ruspoli, che era stato suo compagno
di studi al collegio militare e che in quel momento comandava una
squadriglia di aerei di stanza al campo. Ruspoli, spalleggiato da
un gruppo di piloti, disse chiaramente a Umberto che «non
poteva e non doveva fuggire». L'erede al trono gli diede ragione,
ma aggiunse che non poteva, da soldato, disubbidire agli ordini.
Ci fu un po' di parapiglia e molti giovani ufficiali minacciarono
di trattenere il principe anche a costo di sequestrarlo. Lo stesso
Ruspoli, spalleggiato da alcuni colleghi, si presentò al
fianco di Umberto al re e a Badoglio, ponendo vivacemente il problema.
«Disse Umberto che quella partenza gli pareva un errore e
che voleva tornare alla capitale sganciandosi dal re e dal governo.
"So che rischio la pelle, ma voglio salvare l'onore della mia
casa"» (9). Il re gli rispose che doveva rispettare le
disposizioni del governo. Badoglio, come sempre ansioso di far valere
i suoi titoli e la sua anzianità, gli disse acidamente: «Le
devo ancora una volta ricordare che lei è un soldato, porta
le stellette e deve solo ubbidire».
Così il principe rimase col suo problema di
coscienza insoluto. O, meglio, si attenne, come avrebbe fatto fino
alla fine, agli ordini ricevuti con l'avallo del re. Né in
quel momento né dopo trovò la forza di ribellarsi.
Né, come vedremo, avrebbe potuto trovarla a causa del suo
carattere, della sua educazione e del suo fatalismo.
Il re credeva che il governo, come aveva perentoriamente
richiesto prima di partire da Roma, fosse tutto con lui o stesse
sopraggiungendo. Evidentemente neppure lui sapeva che Badoglio aveva
invitato solo gli esponenti militari, lasciando i civili alloro
destino (10).
Quando giunse finalmente la notizia che la Baionetta
era arrivata in porto, le decisioni furono prese. I reali decisero
di attendere l'imbarco, previsto per la notte, presso i Bovino.
Il re, nel congedarsi, raccomandò per l'ultima volta «che
tutto il governo partisse compatto», poi, accompagnato dalla
famiglia e dagli aiutanti, riprese la via di Crecchio. Badoglio
era scomparso.
Racconta Luigi Cafiero: «La nonna [la duchessa
di Bovino] stava assorta nei suoi pensieri ed era circa l'ora del
tramonto quando arrivò uno dei camerieri, trafelato, dicendo
che si vedevano degli automezzi arrivare lungo i tornanti del vallone.
Questa volta il cancello fu aperto in velocità e tutti noi
andammo ad aspettarli al portone. Era solo la famiglia reale, con
qualche aiutante. La regina e tutti apparivano stanchi e la nonna
fece preparare le stanze. Bice cedette di nuovo la sua al principe
che, incontrandola in corridoio col valigione in mano, le disse
scherzosamente che dopo quel nuovo sfratto loro due sarebbero rimasti
nemici per la vita ... Quella sera nessuno cenò, solo la
regina chiese qualcosa di caldo. La nonna stette a lungo con la
regina e col re. Il nonno e mia madre rimasero col principe che
portava con sé i sigilli di Stato» (11).
Umberto si controllava, ma era vicino alla disperazione.
Appena arrivato fu preso in disparte dal suo aiutante, di Campello,
che quasi piangendo lo dissuase dal proseguire. Non trovò
di meglio che rispondergli con una citazione: «In Casa Savoia
si regna uno alla volta».
Poco dopo, fu proprio la duchessa a sollecitare il
principe, davanti a tutti: «Vostra altezza conosce bene i
sentimenti miei e della mia famiglia verso sua maestà la
regina e verso Casa Savoia, mi perdoni quindi se la scongiuro nuovamente
di tornare a Roma e di mettersi a capo dell' esercito e della resistenza»
(12).
Umberto, che questa volta non aveva sul collo il
fiato di Badoglio, rispose prontamente: «La ringrazio, duchessa,
lei mi reca un grande conforto. Non ci resta che convincere Sua
Maestà, mio padre».
La discussione si riaccende. Questa volta è
Acquarone a ipotizzare che se Umberto tornasse a Roma, i tedeschi
lo catturerebbero, lo ricatterebbero, lo torturerebbero, obbligandolo
a non riconoscere l'operato del padre e a prendere il suo posto.
«Già in Ungheria, con Horthy, si erano comportati così».
All'idea delle torture la regina si commuove ed esclama: «Bepo,
tu n 'iras pas! ». Il re, ostinatamente, ripete che ciò
che ha deciso il governo va rispettato.
Ormai il principe dispera di essere ascoltato, ma
l'idea di disobbedire non lo sfiora. Verso le 21 si ritira in camera
e fa chiamare Puntoni, che poi scriverà: «Lo trovo
in piedi, al centro della camera, a braccia conserte. "La mia
partenza da Roma", mi dice subito, "è senza dubbio
uno sbaglio: penso che sarebbe opportuno ch'io tornassi indietro.
La presenza nella capitale di un membro della mia Casa, in momenti
così gravi, la reputo indispensabile ... ". Cerco di
dissuaderlo, anche perché il sovrano ha espresso il desiderio
di avere con sé il principe ereditario, che rappresenta la
continuità della dinastia ... » (13).
Poco dopo la comitiva reale partì per andarsi
a imbarcare, e il trasferimento diventò incontestabilmente
una fuga. Umberto aveva fatto in quelle ore l'ultimo tentativo di
separare il destino suo e dell'Italia da quello, già segnato,
di suo padre. Tornando a Roma avrebbe potuto giocarsi la vita. O
cambiare la storia. Non gli mancava il coraggio di rischiare, ma
era incapace di disobbedire. Era stato educato fin dall’infanzia
alla sottomissione, che accettava lucidamente, masochisticamente,
talvolta con dedizione quasi morbosa. In quella notte shakespeariana,
cominciava per lui un’agonia che sarebbe durata cinquant’anni.
Note
1) Luigi Cafiero, Da Crecchio a S. Samuele in otto tappe, Arti
Grafiche Laterza, Bari s.d. Luigi Cafiero era uno dei nipoti presenti
alla scena.
2) Luigi Cafiero, op. cit.
3) Lucio Lami, Interviste confidenziali con Umberto, (a puntate),
in Il Giornale, novembre 1979. Re Umberto, durante le mie interviste,
smentì vivacemente di aver pronunciato la frase: «Dio
mio, che figura!» attribuitagli, nel suo diario, dal generale
Puntoni.
4 )Testimonianza di Ernesta Santambrogio, dama di compagnia della
duchessa, presente alla scena, a Manlio Masci, in Ruggero Zangrandi,
1943: 25 luglio-8 settembre, Feltrinelli, Milano 1964.
5) Lucio Lami, op. cit.
6) Luigi Cafiero, op. cit.
7) Enrico Caviglia, Diario (aprile 1925-marzo 1945), Casini, Roma
1952.
8) Gli storici ancora ne discutono, ma i sospetti si appuntano su
Sorice e ancor più sul generale Carboni che era intimo amico
di Kesselring. «Di tutti quanti potevano trattare l'intesa,
da Badoglio, a Ambrosio a Roatta, presenti con la famiglia reale
al Ministero della guerra, la notte precedente, il solo a non esserci
tra le 23 di sera e le 4 del mattino era proprio Carboni»
(Silvio Bertoldi, Apocalisse italiana, Rizzoli, Milano 1998). Altri
storici, come Spinosa e Mazzetti, sostengono che la colonna principale
dei «fuggiaschi», scortata da una dozzina di moderne
autoblindo, fosse tale da suggerire ai tedeschi in ritirata di non
attaccare.
9) Paolo Monelli, Roma 1943, Longanesi, Milano 1956.
10) Secondo la celebre ricostruzione di Ruggero Zangrandi, op. cit.,
il patto segreto stipulato nella notte tra l'8 e il 9 settembre
da Sorice (o da Carboni) con Kesselring prevedeva che a partire
fossero solo i vertici militari e i sovrani.
11) Luigi Cafiero, op. cit.
12) Testimonianza di Ernesta Santambrogio, dama di compagnia della
duchessa Antonia. Di Manlio Masci, in Ruggero Zangrandi, op. cit.
13) Paolo Puntoni, Parla Vittorio Emanuele IlI, Rizzoli, Milano
1958.
-» Il
Re di maggio. Umberto II: dai fasti del «Principe bello»
ai tormentati anni dell'esilio.
di Lucio Lami
360 pag., euro 18,00 (al 12 agosto 2007)
Edizioni Ares, 2002 (Profili)
ISBN: 9788881552405
Cliccare
qui per acquistare il libro.