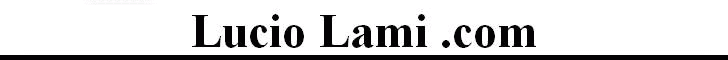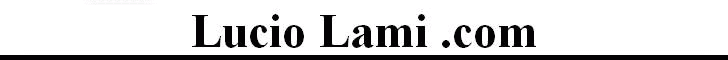» I libri »
Giorni di guerra «
Giorni di guerra
Un inviato nei conflitti dell'ultimo quarto di
secolo
(Di seguito si propongono la prefazione e il
primo articolo pubblicato)
Prefazione
 La
mia generazione, quella arrivata al giornalismo tra la fine degli
anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, è stata l’ultima
ad accedere alla professione «per concorso», cioè
attraverso un periodo di selezione. Sconosciuti, ci presentavamo
impavidi ed asfissianti ai direttori e ai caporedattori dei quotidiani
per essere accolti nella ciurma dei ragazzi di bottega. Non ci venivano
chieste tessere di partito, né raccomandazioni. Per mesi,
dando la caccia alle sedie lasciate vuote dagli assenti, facevamo
un po’ di tutto, gratuitamente o quasi, imparando il mestiere,
nell’attesa di essere notati e giudicati degni di assunzione,
nel giorno imperscrutabile della scrematura.
La
mia generazione, quella arrivata al giornalismo tra la fine degli
anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, è stata l’ultima
ad accedere alla professione «per concorso», cioè
attraverso un periodo di selezione. Sconosciuti, ci presentavamo
impavidi ed asfissianti ai direttori e ai caporedattori dei quotidiani
per essere accolti nella ciurma dei ragazzi di bottega. Non ci venivano
chieste tessere di partito, né raccomandazioni. Per mesi,
dando la caccia alle sedie lasciate vuote dagli assenti, facevamo
un po’ di tutto, gratuitamente o quasi, imparando il mestiere,
nell’attesa di essere notati e giudicati degni di assunzione,
nel giorno imperscrutabile della scrematura.
Vivevamo di ambizioni, di credito nei ristoranti e di esaltanti
letture: Barzini, Lilli, Montanelli, Piovene, David, Monelli, Vittorio
G. Rossi e via elencando: non c’era, a seconda dei gusti,
che l’imbarazzo della scelta. I commentatori politici ci interessavano
poco: per noi, i giornalisti «veri» erano i grandi inviati,
che sentimentalmente collegavamo ad altri padri putativi, da Hemingway
a Dos Passos, da Londres a Saint-Exupéry.
Nei momenti di esaltazione o di depressione giuravamo che, prima
o poi, saremmo stati nel novero. Il «Palazzo», allora,
non ammaliava nessuno. Quant’è passato? Solo un quarto
di secolo, o poco più. E fa una certa impressione leggere
oggi su Le Monde: «Come mai dobbiamo ristampare,
a cinquant’anni di distanza, i grandi reportage di Albert
Londres per accorgerci che nei nostri giornali il tono è
cadente, la prosa anemica, la visuale ristretta, come se nessuno
osasse più? Per questa crisi del reportage, che è
europea, sono state trovate giustificazioni labili: i charter,
il mondo reso più piccolo e banale, l’immagine portata
a domicilio. Saremmo entrati in un mondo che non vuole più
essere raccontato come prima, ma solo mostrato al telegiornale della
sera e commentato l’indomani negli editoriali. Che sciocchezza!».
Se la situazione è questa, le cause vanno ricercate nelle
tre malattie dalle quali il reportage è stato contagiato
in anni non lontani: quella sociologica, quella semantica e quella
ideologica.
Sul finire degli anni Sessanta, la sociologia impose il suo dictat
nell’informazione. Ben presto l’inchiesta giornalistica
si trasformò in sottoprodotto sociologico nel quale i dati
statistici prendevano il sopravvento sulle testimonianze dirette,
i problemi diventavano più importanti dell’uomo, l’elaborazione
delle notizie più delle notizie. Ai neofiti del mestiere
si cominciò a spiegare che quella dell’inviato era
una figura romantica ed obsoleta, estranea alla civiltà del
computer, che una buona documentazione ufficiale o un elaborato
specialistico valevano di più di qualsiasi inchiesta giornalistica.
E fu allora che la categoria si imbottì fino alla saturazione
di chierici e l’editoria di specialisti di mercato, di amministrativi
«taumaturgici». Nasceva un giornalismo senza giornalisti,
fatto di funzionari sedentari, di sociologi, di aruspici e di inventori
di gadgets.
In quel tempo, fu anche rumorosamente annunciata la nascita di
una nuova scrittura, la scrittura giornalistica appunto,
che doveva essere diversa da quella della letteratura, impersonale
e omogeneizzata, tanto che da quel momento, su molti giornali, gli
articoli apparvero come fossero tutti scritti dallo stesso estensore.
Contemporaneamente, si seminò a piene mani il sospetto sulla
«forma», sullo stile personale, retaggi passatisti ai
quali veniva contrapposta la neolingua, espressione del giornalismo
sociologico e politicizzato. La neolingua, nella sua uniformata
povertà gergale, preparava il palato della pubblica opinione
all’assenza di sapori e all’accettazione di dosi sempre
più massicce di agenzie, come fonte alternativa all’indagine
autonoma ed indipendente.
Il virus dell’ideologia trovava a quel punto terreno fertile,
tanto più che da noi non si era mai cessato di prediligere
la dissertazione e non ci si era mai votati, completamente, alla
religione anglosassone della notizia. Nel quadro di un giornalismo
fortemente ideologico, nel quale i giornalisti diventavano sempre
più i rappresentanti dei partiti all’interno delle
redazioni, il grande reportage appariva ormai, a molti, come un
elemento anomalo e dirompente, incontrollabile e capace di fracassare
la simmetria consolidata dei compromessi.
Oggi, il peggio è passato: gli articoli non sono più
così sentenziosi, la buona scrittura ha ritrovato i suoi
estimatori, molti ideologi di ieri si sono trasformati in flagellanti
pentiti.
Restano, in attesa di verifica, quegli anni difficili, durante
i quali a fare l'inviato nella forma tradizionale eravamo rimasti
pochissimi, quasi tutti sopravvissuti in situazioni eccezionali.
Oggi come allora, quelle nostre corrispondenze appaiono anomale:
offrono una visione della realtà, toccata con mano, drammaticamente
diversa da quella generalmente offerta alla pubblica opinione. Corrispondenze
ai limiti della contro informazione, voci sommerse dal coro, che
descrissero la realtà afghana anni prima che l'argomento
si diffondesse sui giornali, il traffico di armi con Teheran anni
prima che esplodesse l'Irangate, che raccontarono della mainmise
della Siria sul Libano, quando ancora i mass media favoleggiavano
di «cantonizzazione», che rivelarono le stragi dello
Chouf, quando l'attenzione della stampa era immobile su Sabra e
Chatila, che testimoniarono dell'attacco mortale di Damasco contro
Arafat quando i nostri ministri lo ridicolizzavano per televisione;
che rivelarono la realtà angolana, dall'interno, quando tutti
gli organi d'informazione internazionale copiavano fedelmente le
agenzie propagandistiche di Luanda...
Ecco, se una ragione c'è, forse, per cui valga la pena
di raccogliere in volume queste corrispondenze - tutte apparse su
«Il Giornale» - è che esse possono servire ancor
oggi come consultazione alternativa. E a futura memoria.
Quello dell'inviato è un mestiere essenzialmente controcorrente.
Mestiere che isola dagli amici, dai riti cultural-mondani, dagli
stessi colleghi. Mestiere che coinvolge la famiglia in maniera talvolta
punitiva. Mestiere malpagato, in confronto ai rischi e ai pericoli
che comporta. «Perché l'ha scelto?», mi domandano
spesso. E la risposta non è cosi facile. Forse, una delle
maggiori attrattive sta in questa possibilità di assistere
agli sconvolgimenti del mondo da un posto di prima fila. C’è
anche il gusto, un po' ironico, di sentir pontificare - a posteriori
- quelli che non hanno visto nulla: molti tra i politici, gli esegeti,
i maîtres à penser.
Come diceva Saint-Exupéry, «L'essenziale non sta
nelle robuste soddisfazioni del mestiere, né nelle sue miserie,
né nei suoi pericoli, ma nel punto di osservazione al quale
ci innalzano».
Nei confronti del potere, la segreta gratificazione sta sicuramente
nel non serviam. Ma una delle molle più forti si
colloca in un doverismo quasi involontario, prodotto dallo stesso
susseguirsi delle esperienze. Perché dopo, quattrocentomila
chilometri dopo il primo reportage, con la mente segnata da tanti
fatti straordinari visti dalle prime file, con negli occhi bellezze
irripetibili o spettacoli atroci come le mattanze di profughi in
Cambogia, con nelle orecchie le antiche musiche africane o le grida
dei bambini iraniani mandati ad aprire varchi sui campi minati...
Dopo, non restano che due strade: il cinismo o la ricerca
di una morale. Ed in quest'ultima, anche un'attività «irregolare»
e randagia come quella dell'inviato acquista un senso non occasionale.
Milano, giugno 1987
Sul fronte Iraq-Iran
Abadan: buio a mezzogiorno
Dallo Shatt-el-Arab, settembre 1980
Le sterminate raffinerie di Abadan sono in fiamme
e qui, tra i soldati che le circondano, si assiste ad un lugubre
spettacolo da apocalisse: è sceso il buio in pieno giorno,
milioni di barili di greggio alimentano questo mostruoso bruciatore
e dalle più grandi installazioni petrolifere del mondo si
leva una colonna di fumo nero, di proporzioni mai viste, che oscura
tutto il cielo, al punto che i fotografi sono in difficoltà
per le riprese. La spera del sole appare solo a tratti, come una
luna artificiale: ne spiove un calore morto e asfissiante, saturo
di gas.
Avevo chiesto al colonnello Muttawa di portarmi sulle
linee ed eccomi accontentato, ma questa è una guerra strana
con prime linee dove le fanterie hanno solo il compito di stringere
in cerchio una città che per ragioni politiche non può
essere forzata, armi alla mano, ma solo colpita dall'alto e al cuore,
un cuore che pompa petrolio: i quartieri civili, in gran parte deserti,
non vengono toccati.
Sono assordato dai colpi delle artiglierie e dai
sibili dei missili terra-terra che vengono lanciati dalla riva sinistra
dello Shatt-el-Arab: da Abadan, gli ultimi gruppi di resistenti
iraniani rispondono con accanimento. A quindici chilometri dalla
città, verso il nord, c'è Khorramshar che gli iracheni
hanno circondata per poi proseguire verso Ahwaz, centoventi chilometri
più a nord. È rimasto questo piccolo fronte insicuro,
tra le due città vicine, nel quale la resistenza è
attuata dagli iraniani con un pericoloso lavoro di infiltrazioni.
Percorro il fronte tra trinceramenti e casematte, nascoste nei palmeti
che costeggiano il fiume: si cammina curvi, sotto il livello del
terrapieno, perché i cecchini sparano su tutto ciò
che si muove.
Sull'altra riva del fiume il terreno è egualmente
insicuro, le infiltrazioni a pettine hanno creato confusione tra
terra occupata, terra non ancora occupata e zone non controllate.
In mezzo, corre maestoso il fiume della discordia, gioiello di quello
che fu uno dei luoghi più lussureggianti dell'antica Mesopotamia,
ridotto oggi ad un'enorme massa di acqua e petrolio che scorre verso
il mare.
La zona è paludosa e questo spiega l'assenza
di carri: le piste che portano al fiume o se ne distaccano sono
ingombre di mezzi su ruote. La strada che da Bassora va ad Al Khali,
cioè verso la foce del fiume dove si inoltrano i grandi tubi
delle pipelines, è stata interrotta dagli iraniani
che hanno centrato l'unico ponte in ferro con assoluta precisione.
Per questo la zona a sud della città, l'Abadan Island, è
diventata un'enorme terra di nessuno sulla quale gli iracheni non
sbarcano difettando di natanti e di mezzi anfibi.
È stata, l'ultima, una notte che mi ha riportato
agli angosciosi ricordi d'infanzia, quelli dei bombardamenti di
Milano. Il cielo era illuminato dai bengala e dalle traccianti:
il tambureggiare della contraerea si mescolava al boato delle esplosioni
e al sibilo dei missili. Quasi non bastasse, le mitragliatrici,
piazzate sui tetti, si erano messe a sparare forsennatamente, non
si sa se per una sorta di scaramanzia o perché i fanti iracheni
credessero veramente di poter abbattere i Phantom in quel
modo.
Stamane ho potuto fare un rapido sopralluogo attorno
alla città e una specie di bilancio: erano stati colpiti
impianti a Bassora, ad Az Zubair e lungo la strada per Bagdad. Ancora
una volta, la guerra era venuta dal cielo. Ormai lo hanno capito
tutti. Solo i soldati iracheni, nel loro fervore, pensano che non
sia cosi e danno grande importanza all'occupazione del suolo, sia
pure desertico. Stamane una lunga schiera di carri è passata
sferragliando sul ponte di cemento che attraversa lo Shatt-el-Arab
e che l'aviazione iraniana non ha ancora colpito: dalle torrette
i capi carro tenevano levato il braccio nel segno della vittoria.
Marciavano verso Ahwaz convinti di dover proseguire ancora, ma probabilmente
li si fermeranno: il presidente Saddam Hussein, dopo la visita del
suo collega pachistano, ha dato segni di ammorbidimento: dice che
è disposto a sospendere i combattimenti se Teheran «dirà
sinceramente di voler riconoscere i diritti degli iracheni».
Per la prima volta, Hussein non ha specificato quali.
Lasciato lo Shatt-el-Arab, con un viaggio fortunoso
mi dirigo con il primo gruppetto di colleghi, cui è stata
concessa l'autorizzazione, nel territorio iraniano occupato dagli
iracheni, lungo il confine nord nella zona dell'altopiano di Kabir.
Mehran, che è segnata sulle carte locali
come una cittadina ma che ha le dimensioni di un nostro borgo di
campagna, si trova ai piedi delle montagne dalle quali scende una
falda d'acqua che consente la vita ai pochi abitanti confinati quaggiù
con alle spalle la catena montuosa e di fronte, verso l'Iraq, trenta
chilometri di deserto. Ci spingiamo in questo scatolone di sabbia
su veicoli militari ripercorrendo la pista tracciata quattro giorni
fa dai T-62 iracheni. A metà strada incontriamo
una casamatta semidistrutta, il segno del vecchio confine, dopodiché
entriamo nel territorio conquistato che altro non è se non
un'enorme porzione di deserto.
Le dune sono ancora solcate dalle tracce dei cingoli,
dalle quali si capisce facilmente che i carri hanno «passeggiato»
uno a fianco all'altro, senza trovare alcuna resistenza. Unica traccia
di guerra, un vecchio carro M-40 iraniano rivolto verso
Mehran, evidentemente colpito mentre cercava di mettersi in salvo.
Sinceramente, non si capisce come l'aver strappato
un po' di chilometri di deserto possa servire agli iracheni per
piegare l'Iran. Ad ogni modo, fatti i calcoli in base alla dislocazione
delle truppe, risulta evidente che l'esercito di Bagdad non solo
ha qui riconquistato quegli ottocento chilometri quadrati di terreno
che nel 1975 erano stati ceduti controvoglia allo Scià, ma
anche una fetta di territorio iraniano valutabile attorno ai due
mila cinquecento chilometri quadrati.
Mentre arriviamo, il cannone tuona ancora e le truppe
stanno compiendo una nuova rapida corsa in avanti di quindici chilometri.
Proseguendo a zig-zag tra le montagne, gli iracheni potrebbero piombare
su Shahabad ed allinearsi cosi con le altre truppe che più
a sud puntano da Amara verso Dezful e più a sud ancora, oltre
Ahwaz. Gli iracheni avrebbero cosi raggiunto il loro obiettivo piantando
tre capisaldi in territorio nemico, parallelamente alloro confine
e conquistando una fascia di .terreno da nord a sud larga circa
centoventi chilometri.
In effetti, tale fascia non è occupata, ma
in zona desertica i capisaldi ne possono consentire il controllo.
È questo un altro dei motivi per cui Saddam Hussein sembra
ora disposto ad ascoltare le varie delegazioni di mediatori che
qui si susseguono.
Mehran è deserta. La gente è fuggita
prima che arrivassero le truppe nemiche. È rimasta solo qualche
famiglia di contadini, nei cui orti pascolano in libertà
alcune vacche magrissime. Sulla piazzetta circolare, dalla quale
si dipartono a croce quattro vialetti ornati di palme, rumoreggiano
i soldati stipati sugli automezzi militari. Gli altoparlanti trasmettono
musiche marziali che il vento porta via assieme ai manifesti politici
strappati dai muri e a una quantità di cartoline postali
che ritraggono Khomeini inginocchiato nella moschea di Teheran.
Chiedo al capitano che mi accompagna che fine ha
fatto la gente del luogo. Risponde: «Non dev'essere molto
lontana e finirà per ritornare», ma non mi sembra convinto.
Il blitz contro il nulla non affascina questi ufficiali che spesso
hanno studiato in accademie straniere, ma esalta la truppa, galvanizzata
dalle trasmissioni propagandistiche della radio, che ancor oggi
gracidava: «Questa è la nostra seconda Al Qadisiah»,
alludendo all'ultimo trionfo di questo popolo sugli odiati persiani,
un trionfo che risale all'ottavo secolo.
-» Giorni di guerra. Un inviato nei conflitti
dell'ultimo quarto di secolo.
305 pag., Euro n.d.
Edizione "I libri del Premio Max David", a cura di www.lampidistampa.it,
2006
ISBN: n.d.
1a ed. 1987 - Mondadori