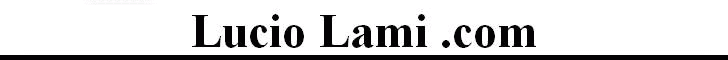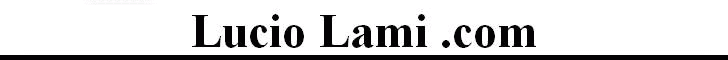» Articoli - 24 febbraio 2004
«
Gibson, Messori e la politica
L’interessante polemica a proposito del film
di Mel Gibson, tra Vittorio Messori e i suoi contraddittori, s’incentra
sempre più sugli aspetti teologici, ma sottace – a
mio avviso – quelli politici, che non sono di minor peso.
Tutto nasce dal fatto che la Passione di Gibson è
fortemente tradizionale, cosa che mette in crisi la sinistra, che
corteggia la Chiesa ecumenica, sociologica e post-conciliare; gli
ebrei, che dopo l’Olocausto sono diventati ipersensibili su
qualsiasi “chiamata di correo”, per lontana che sia
nel tempo, e la stessa Chiesa cattolica che considera il tradizionalismo
come un reperto del passato preconciliare, recuperato solo dalla
destra conservatrice.
Politicamente parlando, il contrasto ha radici lontane.
Nel dopoguerra la Chiesa, che fino al 1945 era stata costantinianamente
con gli Imperi, accettò la democrazia la quale, secondo il
modello di Madison, tollera, in nome della pacifica convivenza,
tutte le religioni, con pari diritti, annullando intrinsecamente
il concetto di Verità assoluta, essenziale (super petram)
nel cattolicesimo.
L’imput sociologico della Chiesa, sposata
alla democrazia, ha comportato problematiche nuove. Innanzi tutto
il ritorno di una tentazione millenarista: l’idea di una società
terrena perfetta, da creare in questo mondo prima che nell’altro,
regolata più dall’amore che dalla giustizia. Poi, l’impatto
tremendo col marxismo, perversa imitatio del cristianesimo,
fino a restarne contaminata con la “Teologia della liberazione”.
Infine, un certo relativismo ideologico che costringe il Vaticano
da un lato a continui richiami su questioni di dottrina (dall’aborto
all’omosessualità) e dall’altro a glissare sulle
conseguenze di una secolarizzazione del mondo cattolico (dal degrado
del clero, alla relativizzazione del Vangelo).
Entrata in concorrenza con la democrazia, la Chiesa
(nonostante i colpi di timone del Papa) lascia spesso alla seconda
la scelta delle armi, ne adotta le tecniche, cerca risposte razionali
là dove vigeva il credo quia absurdum, dovendo rispondere
a chi, operando nello stesso campo, le pone domande in termini storico-razionali
(così si affanna a far passare e ripassare al carbonio la
Sindone per accertarne il valore documentario), e ogni volta che
si aggrappa al dogma si sente attaccare, sul piano politico, da
chi, in campo sociale, ritiene di poterle insegnare qualcosa o da
chi promette di seguirla se accetta “di adeguarsi”.
In questo contesto, i film come quello di Gibson
e le recensioni come quelle di Messori sono visti come ostacoli
all’”adeguamento” non solo dagli oppositori politici,
ma anche da larghe fasce di clero e dei credenti.
Singolarmente, l’incidenza politica della Chiesa
fa sì che i suoi avversari, esterni ed interni, attacchino
chiunque dia segno d’intransigente fedeltà al Libro
(cosa che porrebbe ostacoli al progressismo teologico e politico),
mentre lo stesso attaccamento è considerato un pregio nei
musulmani, almeno in quelli non ancora deviati dalla politica.
Secondo molti, questo atteggiamento, legato più
alle ideologie politiche che alla teologia, nasce dalla crescita
dell’ignoranza in campo religioso. Un acuto osservatore del
fenomeno, Alain Besançon, scriveva già qualche anno
fa: ”Da più di un secolo la Chiesa si sforza di promuovere
lo spirito sociale. Con ciò ha reso grandi servigi alla democrazia
e infatti quest’ultima ha cessato di perseguitarla. Ma la
Chiesa non aiuta la democrazia a guarire da quel deficit di Verità
che è il suo grande male segreto e devastante. Gli sforzi
della Chiesa darebbero maggiori frutti se rivolti a guarire da quel
deficit intellettuale che impedisce alla Verità, di cui essa
si dice detentrice, di fruttificare e di convincere”.
L’impresa, evidentemente, non è facile,
in un mondo dove il messaggio religioso è affidato alla grande
comunicazione ed è sovrastato, spesso anche a causa del clero,
da quello politico. Per questo, ogni volta che qualcuno tenta il
rilancio delle Fonti, come ha fatto Gibson con la sua trascrizione
letterale della Passione, il messaggio viene distorto nell’ottica
politica e le fonti stesse sono messe in discussione, quasi che
la fede fosse una fatto razionale, da supportare scientificamente.
Nello stesso tempo, l’accentuazione sociologica
nel discorso cristiano, fino a confondersi col discorso politico,
non guarisce l’uomo dalla privazione della Verità,
dalla riduzione della Verità ad opinione, anzi lo opprime
e lo mutila, come già avevano intuito intellettuali assai
diversi, da Tocqueville a Flaubert, da Nietzsche a Pégy.
Evidentemente, sia Gibson sia Messori sono della
partita.